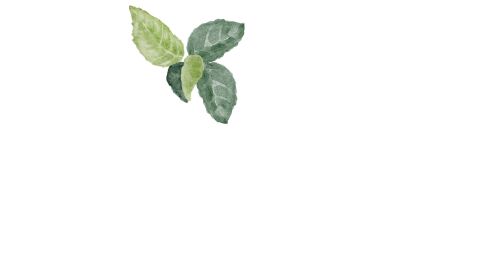Il testo si basa sulla ricerca di Varutti M., Claiming ecological grief: Why are we not mourning (more and more publicly) for ecological destruction?*, Ambio 2024 Apr, tradotta e riadattata al format narrativo di Mycelica. Dove non diversamente specificato, le parti virgolettate sono citazioni dalla ricerca.
* "Rivendicare il lutto ecologico: perché non esprimiamo il nostro lutto (sempre più pubblicamente) per la distruzione ecologica?"
“Cari amici, vi invitiamo a prendervi cura di voi stessi, se volete proteggere l’ambiente. Il benessere del pianeta dipende proprio dal modo in cui trattate il vostro corpo, i vostri sentimenti, le vostre percezioni e la vostra coscienza; allo stesso modo, il benessere del vostro corpo e della vostra mente dipende dal benessere del pianeta. Se non riuscite a gestire il problema dell’inquinamento e della violenza dentro di voi come potete gestire il problema dell’inquinamento e della violenza fuori di voi, nella natura?” Thich Nhat Hanh1
Prologo
Che il mondo naturale susciti in noi emozioni piacevoli e migliori il nostro stato psicofisico è una consapevolezza ormai acquisita. Lo sappiamo dalla letteratura, dalle neuroscienze, dalle pratiche di guarigione delle culture più diverse: imbattersi in orme di animali selvatici nella neve, camminare nel bosco, attraversare una distesa fiorita, veder crescere il noce piantato dietro casa dal nonno… fa vibrare all’unisono corde emotive e psichiche e poetiche e neuroendocrine che confortano, rallegrano, calmano, sublimano.
Quello che forse non sapevamo, e che solo da pochi decenni stiamo scoprendo grazie alla psicologia del clima è che ciò che accade alla natura può muovere in noi anche emozioni fortemente negative. E non potrebbe essere diversamente.
Se non avessi un bosco proprio dietro casa, me ne sarei andata a vivere altrove da tempo. È un piccolo bosco residuale come se ne vedono molti nella pianura padana; all’inizio erano pochi alberi risparmiati dall’edilizia e dalle monoculture che tappezzano l’area per chilometri, oggi una piccola selva a guardia della soglia tra città e campagna. Quello che mi tiene ancora qui, mentre la cementificazione avanza e villette storiche vengono rase al suolo per costruire palazzi-bunker, è il fatto che mi basta aprire le finestre perché la casa sia inondata di grida di scoiattoli e ghiandaie.
Il terrazzo di prua affonda in una tavolozza di verdi che mutano durante tutto l’anno: pioppi, lecci, tigli, salici, rovi, che negli anni si sono stretti in un abbraccio così impenetrabile che solo piccoli animali riescono a farvi tane e nidi. Da lì nelle giornate estive sale il fragore assordante di cicale, per darsi il cambio al tramonto con il richiamo ritmico degli assioli. Durante le passeggiate più fortunate può accadere di vedere un grande airone cenerino alzarsi in volo dal canale che circonda il bosco e planare maestoso qualche centinaio di metri più in là, dove finiscono gli alberi e iniziano i campi. Ho scoperto che da almeno quindici anni si fa fotografare lungo i molti corsi d’acqua della città.
Da qualche tempo ho cominciato ad avvertire la paura che questo angolo di paradiso scompaia – spazzato via come le villette liberty – e che non ci sia modo di impedirlo. È una paura che si è insinuata sotto pelle e che ogni tanto affiora in un’allerta sottile. È come il presentimento di una perdita imminente che alterna preoccupazione e rabbia, impotenza e tristezza.
Le stesse emozioni che provo di fronte al vuoto lasciato dall’abbattimento di interi filari di alberi per costruire la nuova linea del tram, o ai tronchi - decapitati dalla notte al giorno - di due platani secolari sacrificati all’interesse economico. O ancora per i moncherini delle capitozzature che spuntano da giardini privati e viali pubblici, e per le potature selvagge non curanti delle norme a tutela della stagione di nidificazione. A queste perdite locali si aggiungono le notizie che arrivano da lontano: nuovi disboscamenti nella foresta amazzonica, ghiacciai che scompaiono per sempre, specie animali e botaniche in estinzione.
Se ne parla tra amici, con i vicini di casa. Ne emerge un malessere comune e una posizione condivisa: se è possibile arrivare ad accettare il senso di impotenza di fronte a catastrofi ambientali al di fuori del nostro controllo (eruzioni vulcaniche, terremoti…), questo non è possibile - né opportuno - quando si tratta di eventi che potrebbero essere evitati perché dipendono direttamente o indirettamente dal comportamento dell’uomo.
Stiamo già tracciando i paesaggi emotivi che chi si occupa di psicologia del clima conosce bene. Da alcuni decenni si parla di “ecoansia”, di solastalgia, di “dolore ecologico”, fenomeni sempre più diffusi. È l’ambito della psicoterratica, espressione con cui Glenn Albrecht descrive i disturbi psichici legati allo stato di salute della terra in seguito ai cambiamenti climatici.
Se la solastalgia è il dolore nostalgico, il senso di perdita che proviamo per un ambiente nel quale pure ancora viviamo ma che è stato violato, distrutto, sacrificato, l’ecoansia è la paura persistente che si verifichi un disastro ambientale, paura innescata da minacce reali come eventi a cui si è assistito direttamente o indirettamente.
“La solastalgia è un tipo di nostalgia di casa o malinconia che provi quando sei a casa e il tuo ambiente familiare sta cambiando intorno a te in modi che ritieni profondamente negativi”. Glenn Albrecht
Ma un costrutto più recente – quello di lutto ecologico – illumina con particolare forza il micelio di connessioni tra umano e non umano, rivelando ancora una volta come la nostra relazione con il mondo naturale sia specchio del rapporto che abbiamo con noi stessi. Una leggenda messicana ci aiuta a raccontarlo:
![]()
Questo contenuto è riservato agli abbonati.
Accedi o Abbonati a Mycelica per continuare a leggere.