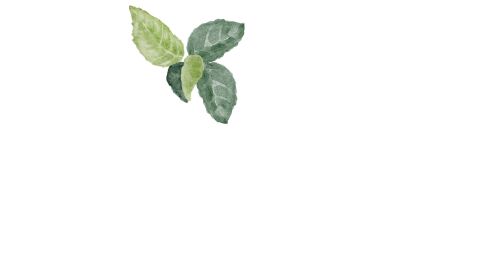Le interviste di Mycelica a donne che hanno attraversato i mondi e le notti buie dell’anima per divenire se stesse. Viaggi che a posteriori si riveleranno iniziatici.
Poesie come corpi che abitano la terra. Poeti e cantastorie hanno il dono e il talento di trasformare la nostalgia in desiderio: quello di tornare a sentirci parte di un’unica matrice.
Come sempre quando ci si presenta, ero pronta a partire da studi e professione. Vorrei provare una strada diversa.
In fondo tutta l’idea di Mycelica ruota intorno al desiderio di decolonizzare il modo in cui pensiamo, parliamo di noi, abitiamo il tempo e lo spazio, amiamo, viviamo. Al cuore di Mycelica batte un urlo liberatorio ancora un po’ strozzato che chiama a raccolta ciò che ancora resta di autentico, sentito, poetico e naturale.
“Decolonizzazione” è una parola che mi fa respirare meglio. Evoca eserciti che si ritirano, esondazioni che rientrano nei letti dei fiumi. Il ritorno di un silenzio, di una quiete, di un passo leggero che accarezza il terreno invece di ferirlo.
Mi fa pensare a qualcuno che finalmente chiede scusa per aver esagerato e prova a riparare. E noi abbiamo decisamente, troppo esagerato. La terra è ferita e l’umano è ferito dello stesso taglio.
La terra e noi. Credo di essere stata attratta fin dai tempi dell’università dalla sfida di riunire i frammenti in cui la visione cartesiana ci ha definitivamente smembrati. E di riunire i lembi di una separazione ancora più antica e cruciale: quella tra umano e natura.
Le storie sono un incredibile filo da sutura. A partire dai miti, dalle fiabe: narrazioni di viaggi sul confine tra dentro e fuori che cuciono insieme passato, presente e futuro. Il micro e il macro. L’io e il noi, i margini slabbrati di una comunità, di un individuo. Il piccolo sé e il grande Sé.
Le storie curano, ispirano, offrono riparo, slancio e orientamento. Lo vedo lavorando con la psicoterapia, che potremmo anche definire: cura della propria narrazione. “Ogni vita merita un romanzo”, diceva Erving Polster: i sintomi hanno storie da raccontare e se ascoltati possono tornare parole incarnate.
Sommare tra loro i frammenti di un intero non è esattamente come se quell’intero non fosse mai stato diviso, ma si può almeno tendere verso quell’unità. Così, dopo la formazione in psicoterapia, mi sono spinta verso tradizioni di cura che non hanno mai separato mente, corpo e spirito, visibile e invisibile, uomo e ambiente naturale, per leggere da una prospettiva più ampia i sintomi individuali e collettivi di una società sempre più complessa. Ho studiato naturopatia, yoga, esplorato lo sciamanismo amazzonico, saltando più volte avanti e indietro lo steccato del metodo scientifico e tornando puntualmente con più domande e meno certezze di quando ero partita. Ma anche questa è decolonizzazione, a pensarci bene.
Per trovare infine nell’ecosofia un orizzonte di sapere abitabile anche da chi non può rinunciare a un certo nomadismo di pensiero: radici profonde e rami tesi al cielo, un dialogo costante tra antiche e moderne conoscenze, e una visione che se non può essere letteralmente unitaria, fa di tutto per avvicinarvisi.
Silvia Riccamboni