È una gioia inaugurare la rubrica “le interviste di Mycelica” con Roberta Schembri, farmacista omeopata specializzata in fitoterapia e floriterapia, ricercatrice di miti, piante, archetipi e alchimia. Ideatrice di Erboristeria Narrativa e dell’omonima Accademia.
Roberta ha dato vita a qualcosa che prima non c’era. I suoi fitoarchetipi fanno parlare tra loro mondi che spesso esitano a rivolgersi la parola: spiritualità, ecologia, psicologia, metodi di cura… e molto altro che qui ci racconta.
Roberta, perché abbiamo bisogno di storie?
Credo che non sia un bisogno, ma un istinto innato. Questo istinto innato che abbiamo è come una facoltà, un organo di senso: il narrare. E questo organo di senso ci permette di osservare e anche di farci osservare dal resto del mondo e quindi di entrare in relazione. È qualcosa che in realtà non decidiamo. Sono le fiabe – quelle più vere, quelle più forti, quelle più profonde, quelle che riescono a toccarci, che di solito sono le più antiche, le più archaiche. Oppure abbiamo la narrazione moderna, ma che si rifà sempre a degli strati fossili del racconto. Hanno tanto in comune con i sogni. Anche qui: non è che decidi di sognare e sogni: arrivano. E quando ti vengono raccontate le fiabe da bambino, non è che tu chiedi la fiaba: ti arriva. Ti arriva questo alimento, un alimento energetico che è proprio così tipico, è così identificativo della razza umana che crea subito l’appartenenza. Quindi prima di tutto abbiamo bisogno di storie per sentirci interconnessi gli uni agli altri.
Ma non solo in senso orizzontale. Cioè non c’è la mamma o la nonna che racconta al bambino, oppure l’adulto che va al cinema e un regista gli racconta una storia. Ma un racconto che non è solo nello spazio, è anche nel tempo. Ci collega a qualcosa che esiste da milioni di anni prima di noi e che continuerà ad esistere. Quindi noi siamo all’interno di una rete che abbraccia tutte le dimensioni.
Quando abbiamo più bisogno di storie? Probabilmente quando ci sentiamo soli e persi. Perché creano subito la connessione, e non solo con gli altri esseri umani ma con tutto il resto del mondo, tutte le altre razze. Perché anche loro fanno parte di questo racconto. E quando siamo persi è perché qualcun altro prima ci è passato. Certo che la nostra storia è unica, però ci sono degli elementi che si ripetono con tutte le variazioni sul tema. Ma il tema è condiviso da ciascuno di noi. Quindi questo ci individua e al contempo ci toglie il fardello di essere un individuo a tutti i costi.
Hai parlato delle fiabe più arcaiche. Gli studiosi ci dicono che all’inizio era il rito, poi questo fu sostituito dal mito e quando anche il mito non potè più contare sulla cultura che lo aveva tenuto in vita, come la fenice rinacque fiaba. Quanto è importante nelle fiabe questa origine-matrice rituale e mitologica, sepolta negli strati più profondi, che noi leggiamo e raccontiamo anche oggi?
È fondamentale, sia da un punto di vista fisico che psichico. Perché abbiamo bisogno del rituale. Anche questo è un istinto, ne stiamo riscoprendo il valore – come sempre succede e sempre è successo nella storia del mondo – ora che ci accorgiamo che manca. È la stessa cosa per cui ci accorgiamo di amare qualcuno quando non lo abbiamo più, quando se ne è andato. È la stessa cosa con il tempo della narrazione ma anche con il tempo del rituale.
Curarsi è un rituale. Per esempio, con la mia professione posso consigliare di prendere l’arnica per un mal di schiena e all’inizio dire “Prenda la compressa”, “Prenda le gocce ogni quarto d’ora, per due ore di fila, poi quattro volte al giorno”, ma c’è una resistenza a questo rituale. E’ un rituale minimo se ci pensiamo, non bisogna salire sulla montagna, non bisogna andare a cercare la Baba Yaga, non bisogna trovare l’albero delle mele d’oro, la fonte della giovinenza, non è questo. Eppure è qualcosa che ci mette già in crisi perché in questa modernità, in questa contemporaneità, abbiamo un rapporto difficile con il tempo.
Il rituale scandisce il tempo. Anche la fiaba ti porta – “C’era un volta, tanto tanto tempo fa…” – in una dimensione del tempo che non è soltanto spostarti da dove sei adesso, ma anche entrare in un altro ritmo che è il ritmo della guarigione. La ripetizione è quello che per esempio la medicina naturale richiede per l’assunzione del rimedio.
Non è tanto “quanto è potente”, come nella farmacologia chimica: se ne metto un grammo… se ne metto mezzo grammo… allora un grammo mi farà meglio rispetto a un mezzo grammo. Lì non funziona così. Quanto più vado al ritmo e quanto più acuto è il problema, o il mio sintomo, tanto più di frequente io devo assumere il rimedio. E man mano che sto meglio posso diradare, e poi c’è un mantenimento, e poi c’è l’uscita dalla fiaba. Si sospende l’assunzione del rimedio esattamente come ci si dovrebbe svegliare la mattina, cioè indugiando in quello stato che è uno stato di coscienza diverso, quasi di semi-trance. Con la fine del rimedio, quando sappiamo che ci ha fatto effetto? Tipicamente quando a un certo punto ci si dimentica di prenderlo, o quando ci si ricorda ogni tanto; quindi c’è questa diluizione.
La fiaba segue il ritmo della marea e anche la guarigione nel nostro corpo segue lo stesso ritmo, che alla fine è l’inspirazione e l’espirazione universale. Già il fatto di connetterci a quella manda degli impulsi attraverso i nostri neurotrasmettitori ai nostri organi, e quello è fondamentale per canalizzare un reset, oppure per cercare di adunare il nostro sistema immunitario, i nostri meccanismi di auto-riparazione. Dobbiamo liberare la strada.
Con Erboristeria Narrativa hai dato vita ad un modo di accostarsi alle fiabe e ai miti, ad ogni trama narrativa in realtà, del tutto nuovo e originale. Come è nata questa intuizione-ispirazione?
È nata in un momento di grande quiete, in un pomeriggio di fine estate del 2019, in uno di quei momenti rari in cui non pensavo a niente, non elucubravo su niente, non ero lì a interrogarmi del senso della mia vita, non ero lì a pensare a cosa dovevo fare da grande: non c’era nulla. Però tutto quello che avevo esplorato nel corso della mia vita è come se proprio in quel momento di sospensione avesse avuto modo di agglutinarsi da sé, di compattarsi, di interagire con quello che mi appassionava di più per il mio lavoro, che erano tutte le branche di medicina naturale. Dalla spagiria all’omeopatia classica, alla floriterapia secondo il metodo di Bach, alla gemmoterapia.
Nel corso dei primi vent’anni dei miei studi, subito dopo l’università, mi ero appassionata a tutto quello che era la medicina non solo olistica ma anche integrata, perché non ho mai escluso, mai inserito un pensiero separativo del tipo “o questo o quello”. Non ho mai simpatizzato per nessuno schieramento, ma fin da piccolissima ho sempre avuto la predisposizione, la costituzione, per un approccio di sintesi. Probabilmente per un metodo analogico piuttosto che logico, per questa ricchezza nel mondo in cui c’è un enorme ventaglio di possibilità a cui possiamo attingere e nessuna, se ci pensiamo, esclude l’altra.
In quel pomeriggio d’estate in me si è creata un’agorà in cui tutte queste comparse, tutti questi partecipanti, tutti questi abitanti dei miei mondi interiori hanno iniziato a danzare insieme. Soprattutto le piante sono state protagoniste, sono state richiamate da un lavoro bellissimo condotto da Stefano Mancuso di cui avevo letto di sfuggita un trafiletto, un articolo della Stampa uscito proprio pochi giorni prima. Un lavoro chiamato Simbiosia, dove si dimostrava che i cerchi concentrici dei tronchi non sono solo una data di nascita, quindi una carta di identità cronologica dell’albero, ma in quei cerchi si riesce a leggere tutto quello che la pianta memorizza, interiorizza. Questo tipo di ricerca, non so perché, mi aveva commossa profondamente, ma era rimasta lì (ritorno sul tempo: abbiamo bisogno anche di questa incubazione, di decanter). E questo si è agganciato in maniera totalmente imprevista e imprevedibile con la trama circolare di tutte le fiabe, cioè con l’altra mia passione che è sempre stata quella della narrazione, di cercare storie, non solo le fiabe.
Io sono partita dai miti. Tutti gli aneddoti, tutte le curiosità sulla mitologia: era proprio un argomento che fin da piccolina mi appassionava moltissimo. E poi in parallelo le fiabe, i film, i romanzi, le storie più intense, quelle meglio costruite. E la trama, che avevo sempre letto tra le righe, si è sovrapposta come un codice a quella che nel lavoro di Mancuso era così chiaramente visibile da una trasposizione informatica dei cerchi delle fiabe. Lì c’è stata come un’intuizione, un big bang per me: è stato come aver letto gli stessi caratteri stenografici sia dentro l’albero che nelle storie. Come un’impronta digitale, come un DNA, un DNA magari “sotto sopra sopra sotto” ma che combaciava perfettamente: la crescita, lo sviluppo, le diramazioni, i vari cicli, i cicli delle stagioni, vita-morte-vita. Le tappe del viaggio dell’eroe erano – per quanto riguarda il nostro emisfero naturalmente – quelle di natura, quindi i rituali legati all’agricoltura, alla fertilità, ai buoni auspici, che venivano metaforicamente trasposti nei miti e nelle leggende.
È stato come scorgerne la filigrana in controluce. Quello mi ha tolto il respiro, è stata un’emozione fortissima, come tutto quello che è condensato in un secondo. C’è stata la voglia incredibile di condividerla subito con altri, ma come passare questa intuizione? Come fare entrare, come ricordare negli altri questo sentimento narrativo, ecologico, di crescita del proprio sé, per ripescare le proprie risorse, il proprio essere inseriti in una struttura talmente perfetta, complessa, animata, mai indifferente? Quella è stata la mia prima idea, il primo “Eureka!” germinale di Erboristeria Narrativa.
Le fiabe evolvono con il tempo e cambiano con la geografia – pensiamo alle decine di versioni di Biancaneve – ma ci sono dei nuclei fondamentali che restano invariati. Uno è la struttura – descritta da Joseph Campbell come Viaggio dell’Eroe – un altro, in un’ottica junghiana, la dimensione archetipale. Puoi dirci qualcosa riguardo a questa geografia narrativa?
Soprattutto in questi ultimi anni è comune, parlando anche con tanti pazienti, la percezione di avere tante parti di noi stessi. Con il dramma che ne deriva: “Ma chi sono? Perché ho reagito così? Non mi piace quando reagisco così. Io non sono così, non sono una che si arrabbia. Allora perché mi sono arrabbiata?” Ci sono delle domande molto semplici ma molto severe, molto dure che ci facciamo. Ci sono degli aspetti di noi che non accettiamo, che gestiamo molto male. E poi ci sono dei punti in cui ci inceppiamo. Questo si può ripercuotere anche a livello fisico, perché – non è filosofia ma ormai è scienza – da uno stress mentale molto forte tutto l’apparato gastroenterico ne risente. Abbiamo proprio un asse cerebro-intestinale che è un asse prima di tutto nervoso, oltre che endocrino.
Jung è stato un grande maestro come lo sono stati in tanti. I suoi studi mi hanno ispirata così come quelli di Joseph Campbell, quelli di Hillman, quelli di Fromm. Ci sono stati grandissimi studiosi che hanno aggiunto ogni pixel nel mio lavoro ed è stata come una comprensione che parliamo lo stesso linguaggio, che è fatto di più aspetti. Questi tanti aspetti, andando a ricercare non solo le fiabe ma anche il mondo di natura, ci accorgiamo che sono chiaramente non solo normali ma anche necessari.
Per esempio: la mitologia slava e russa. Ho studiato molto queste mitologie, queste tradizioni folcloriche. Perché l’Europa dell’Est e soprattutto il nord-est europeo, quindi la cultura che un tempo era dei prussiani o dei baltici? Perché loro, rispetto a una cultura più mediterranea o sudamericana? Perché dove ci sono le foreste più selvagge è come se gli intrecci, le trame di cui parlavamo prima, fossero più evidenti. Perché quelle sono, e in parte sono rimaste, delle foreste incontaminate dove la bellezza drammatica di quelle condizioni e di quel convivere con il mondo di natura – madre e matrigna – ha trascritto meglio che chiunque altro. Per questo i russi secondo me sono maestri della narrazione, perché hanno più boschi.
Perché non si sono intaccati così tanto, tutto sommato per loro era impossibile farlo. Quindi la foresta era sì il luogo dove ci si perdeva, ma anche il luogo dove ci ritrovava; dove trovavi farmaci, dove trovavi da mangiare, la legna per scaldarti, per costruirti la casa. Quindi era proprio una relazione intima più che per altri popoli; subito dopo, forse quasi pari e patta rispetto ai russi, agli islami e ai balti, ci sono i germanici e i celti, perché proprio dove ci sono queste foreste si sviluppa l’humus fertile per le fiabe. Perché è dove ci sono i chiaroscuri più forti che riverberano proprio con queste tante parti, non solo dei nostri archetipi, dei nostri mondi interiori, ma anche delle varie tappe, come dicevamo.
Per esempio le Vily e le Beregini sono figure femminili straordinarie che ritroviamo nella mitologia, nel folklore e nelle fiabe russe, e sono formate a volte da 30, o da 3 volte 9, o da 7, o da 3 sorelle; quindi è una struttura della psiche unica eppure ramificata. Perché in un contesto così animista come quello che si sviluppa a ridosso del paganesimo, e in tutto quello che è istintivamente intuibile all’interno di un mondo selvatico con cui dobbiamo fare incontri (e con cui oggi è più che mai urgente fare i conti), non c’è niente di straordinario a parlare di frammentazione della propria psiche, in un movimento di diversificazione e quindi di biodiversità per poi ritornare alla sintesi dell’unità.
Credo che questo sia un punto di altissima spiritualità, non solo di ecologia, non solo di psicologia e non solo di metodi di cura. Tutto questo è una ricchezza, conoscere tutto questo substrato non può che ispirarci, qualsiasi sia la nostra chiamata, la nostra professione, la nostra predisposizione, la nostra questione, quello che più ci sta a cuore. È ispirante.
Come c’entrano le piante con gli archetipi e come possono le piante sostenere il viaggio dell’eroe?
La biodiversità di cui si parlava è il tema centrale. Sarebbe per noi sterile, alienante mangiare lo stesso cibo tutti i giorni, oltre che non sano; abbiamo bisogno di più mattoncini, abbiamo bisogno di più relazioni, abbiamo bisogno di più esperienze, anche con la sempre più carente capacità di lasciare avvenire tutto questo e di non farci contaminare da tutto questo. Nelle piante abbiamo un tale repertorio, un tale database, un tale archivio di rimedi fitoterapici che hanno caratteristiche così uniche e specifiche, e anche soltanto dalla forma o dalla varietà appunto infinita ci accorgiamo che per ogni nostra sfumatura di patologia può – e infatti così è – corrispondere un rimedio preciso.
A seconda della costituzione della persona o a seconda della costituzione che il paziente ha in quel momento della sua vita, perché siamo in trasformazione, siamo uno, nessuno e centomila; magari siamo quelle Vily che sono diramate in 30 o in 27 o in 7 o in 3, ma quale ha quel disturbo? Qual è la trentesima o la quinta o la dotticesima che ha il mal di pancia? Allora è più difficile ridurre a un protocollo, perché quando sentiamo la storia del paziente, l’emozione collegata a quel disturbo, la sua difficoltà o magari qualcosa che è apparentemente capitato per caso – una frattura, una storta, un raffreddore, delle verruche – c’è poi la più angosciante e la più illuminante delle domande: “Perché?” L’essere umano non si dà pace e continua nella sua non accettazione, ma se abbiamo questa spinta a chiederci il perché è giusto ascoltarla, non possiamo risponderci fino alla fine “Perché è così”.
L’essere umano non lo accetterà mai questo perché è un esploratore, è un ricercatore. Tutti lo siamo. Ecco la sapienza antica: non si coltivavano piante negli orti, si coltivavano dei, perché? Perché proprio come i personaggi delle grandi storie, che hanno alcune caratteristiche, alcuni tipi di comportamento, anche le piante hanno comportamenti differenti: se tocco una mimosa pudica non è la stessa cosa che toccare un cactus. E reagiscono e sono strutturate per un tipo di reattività completamente diverso: una pianta carnivora non mi darà neanche a vederla la stessa impressione di una rosa, eppure hanno entrambe le spine.
L’osservazione si prendeva tutto il tempo per andare nel mistero di quel genio vegetale. Quello che veniva percepito a livello di sensi, a livello di istinti, ha fatto sì che tra tutte le piante per il bruciore di stomaco, o per il mal di testa, o per una cistite, non tutte mi vadano bene: perché? Oppure quella pianta, quel rimedio, va bene a 3 persone su 5 e le altre due non rispondono: perché? Questo è l’approccio più olistico e scientifico al tempo stesso che mi viene da supportare e da sperimentare tutti i giorni nel mio lavoro.
A proposito di questo, scegliere quale fiaba “prescrivere”, quale raccontare, vale come per le prescrizioni fitoterapiche, che sono valutate in base alla persona e al suo momento di vita? Puoi farci un esempio?
Ci sono volte in cui la persona ti parla molto chiaramente, e quando la narrazione è così chiara in genere è perché siamo in un’urgenza. Essere nell’urgenza, che è una cosa che molto spesso neghiamo a noi stessi, in realtà è la condizione più positiva per intraprendere qualsiasi tipo di lavoro o di esplorazione del sé, perché abbiamo bisogno di star bene e abbiamo bisogno di star bene in fretta, non tra dieci anni. Questo non si sovrappone naturalmente ai lavori di psicoterapia, che hanno bisogno del loro tempo, questo è uno strumento che si affianca.
Ci sono volte in cui la persona ti dice che le sembra di avvertire un senso di solitudine interiore enorme e tu magari puoi chiedere come va con la famiglia d’origine, dove si sono interrotte queste relazioni. Allora la persona ti racconta che la famiglia d’origine pretendeva un certo tipo di risultati, di comportamento, di adeguatezza, di produttività, di essere vincenti, di non creare disturbo, eccetera. Era molto comune fino a una o due generazioni fa richiedere questo ai figli. Qui già cominciamo a intravedere le prime protagoniste delle fiabe, di solito sono tutte quelle rappresentate come fanciulle che sentono questa solitudine, o perché sono la figlia dell’altro matrimonio, come Cenerentola o Biancaneve, o perché sono troppo fragili come struttura in mezzo alle pretese della famiglia, di solito con una voce paterna interpretata come molto forte. Abbiamo ad esempio La fanciulla senza mani, oppure potrebbe anche essere la figlia del mugnaio in Tremotino: devi dimostrare quanto vali.
L’ansia della performance è molto forte nella nostra società e ci sono delle fiabe che la descrivono a stampatello, a chiare lettere. Cosa succede quando siamo nell’ansia della performance? La prima cosa che facciamo è esattamente quello che fa la figlia del mugnaio di Tremotino, cioè non dormire, passare tutta la notte in mezzo a queste montagne di problemi che sono i covoni di paglia e non sapere come diavolo trasformarli, tutti questi problemi di paglia, in fili d’oro. In più sentiamo la scadenza del tempo perché abbiamo la rata del mutuo, perché dobbiamo pagare l’affitto, dobbiamo gestire il quotidiano. E’ interessantissimo poi vedere quali strumenti di risoluzione del problema ci offrono le fiabe e come possiamo tradurli nella nostra vita, nel nostro ambiente interiore.
Quando racconti le fiabe, mi accorgo di due movimenti che si attivano nell’ascoltarti. Uno più cognitivo, razionale, che cerca di decifrare e comprendere il senso della fiaba. E uno più sotterraneo, viscerale, che segue “leggi” molto diverse da quelle corticali. Riduttivamente verrebbe da dire che ogni fiaba può essere capita e/o vissuta: quanto del suo potenziale trasformativo risiede nell’uno e nell’altro movimento? A che “livello” agisce la fiaba?
Su tutti: è un’armonizzazione. Si chiamano intrecci proprio perché ci sono almeno tre funzioni, per esempio nel modello antroposofico quella del volere, del sentire e del pensare. O potremmo declinarlo a seconda di tutti gli altri modelli che sono stati proposti dagli studiosi nel corso dei secoli.
Parliamo dell’essere non solo completamente partecipi, ma anche del provare quel sottile senso di cinetosi, di disorientamento. Questo è auspicabile perché l’essere umano ha il sacrosanto bisogno e diritto non solo di emozionarsi, ma di provare meraviglia. Allora, quando è disorientato – e Alice nel paese delle meraviglie ce lo insegna benissimo – non deve capire, deve reggere un certo lasso di tempo in cui non c’è chiarezza. E’ come farsi il muscolo, perché non sempre le cose nella vita sono chiare – anzi quasi mai.
Cercare la chiarezza, la comprensione, il senso, la bellezza, sono dei movimenti attivi dell’anima. E’ giusto che il mondo sia anche e forse soprattutto brutto, perché così l’anima – la nostra psiche profonda – è chiamata a un moto interiore attivo di ricerca della bellezza. Non ci può venire servita, già pronta, in continuazione. Anzi: le autostrade saranno più comode, però avviene molta poca storia. Questa è nei sentieri più impervi. Noi abbiamo questa capacità di comprendere, di sentire, di avere – come dice Pretty Woman quando va a sentire l’opera – che “Mi si sono attorcigliate le budella”. E mentre sente l’opera si chiede: “Ma visto che è tutta cantata, come faccio a capire quello che dicono?”
Meno capisci razionalmente, più in qualche modo può accadere qualcos’altro. Queste fiabe noi le conosciamo già, le possediamo già, per questo sarebbe riduttivo, dopo l’età dell’infanzia, dopo l’adolescenza, fermarci alla sola lettura della fiaba. Perché è qualcosa che ci unisce in cerchio, in una rete, il fatto di poterne parlare, di vedere quali sono i punti di forza, di raccontare cos’è che ci risuona, quali intuizioni nuove ci ha generato. Tutto diventa più vero quando abbiamo dei testimoni, quindi questo è anche un lavoro collettivo.
C’è una relazione speciale tra le donne e le erbe curative – testimoniata dalla preponderenza di donne iscritte alla tua Accademia, ai corsi di erboristeria, di raccolta di erbe… Purtroppo è un filo rosso sangue, se pensiamo alle decine di migliaia di guaritrici finite sui roghi (50.000 in Europa). Questa relazione speciale ha radici molto lontane che, come i nuclei narrativi delle fiabe, resistono nonostante il passare del tempo e i cambiamenti culturali.
Da cosa può cominciare una donna che senta oggi questo richiamo? Come può ricollegarsi a questa genealogia nel suo quotidiano, con quali gesti?
Le donne sì, ma forse in generale il lato femminile, perché anche tanti uomini sono assolutamente attratti da questo. Il femminile perché la sua caratteristica è il ricevere: la descrizione della donna può cambiare da cultura a cultura, e anche la donna oggi può essere molto diversa rispetto a quella di 5-6 generazioni fa, ma c’è una costante nel femminile che è proprio la ricezione.
Nel nostro buio misterico, al nostro interno, nel nostro calderone magico, riusciamo – proprio come è successo a me in quel pomeriggio d’estate – a far dialogare tutti gli ingredienti. È qualcosa che è anatomicamente già presente in ognuna di noi, quindi quello che posso suggerire di fare, se già non lo si sta facendo, è di custodire. Noi siamo delle grandissime custodi: custodiamo segreti, custodiamo emozioni, custodiamo ricordi, custodiamo dettagli. Le piante e le fiabe hanno in comune questo: ci parlano, ci agganciano attraverso un dettaglio preciso, quasi mai con l’insieme. Non è tutta la fiaba che ci colpisce, non è tutta la pianta che ci richiama dal bordo della strada, in genere è un minuscolo particolare che intrasentiamo o intravediamo con la coda dell’occhio. Siamo cronobiologicamente selezionate per questo, cioè l’attenzione al dettaglio: qual è il dettaglio nella fiaba del Principe ranocchio che mi colpisce di più? Magari è quella pallina d’oro nel buio della foresta cupa, oppure è il grambiule di Alice, oppure sono le scarpette rosse di Dorothy, o il sentiero dei mattoni dorati.
Ricorderò un frammento e quel frammento corrisponde al kairòs, cioè l’istante: quel buco attraverso la trama del cosmo attraverso cui mi arriva un raggio di luce. Vengo agganciata da qualcosa che non ho messo ancora a fuoco del tutto e lì mi attivo con la curiosità, che è l’unica facoltà richiesta per approcciare questo mondo. Per le piante è uguale: magari la pianta investe tutto nel colore di quella bacca, o certe volte sono quelle velenose, una Belladonna, con quella ciliegia viola quasi nera che poi è stata soprannominata “la ciliegia del furore”. Così invitante, così accattivante, così promettente, non si può non rendersi conto che viaggia alla stessa vibrazione di quell’estetica meravigliosa e inquietante della mela stregata di Biancaneve.
Qual è la promessa lì? E qual è quel senso del tradimento che l’anima sente quando quella bacca è tossica, quella mela è avvelenata, quella amica che ci faceva tutti quei complimenti ci ha pugnalato alla schiena? È lo stesso tipo di reazione epidermica e fisiologica e a cascata che proviamo se ci spostiamo su quelle stesse frequenze.
Erboristeria Narrativa è la dimostrazione che non siamo costretti a scegliere tra scienza e “magia”, tra capire e vivere, tra emisfero sinistro e destro, tra logica e poesia, tra materia e spirito. Nel tuo metodo c’è tutta la solidità del dato scientifico – le azioni dei fitoterapici su organi e funzioni – e la creatività intuitiva, il potere dell’azione simbolica-immaginale. Come hai distillato il tuo metodo di lavoro con le persone?
È un lavoro metodico, infinito e certosino. Innanzitutto c’è un lavoro di ricerca, perché è come se si fosse scoperchiata la caverna delle meraviglie. Oltre alle fiabe famose ci sono tante di quelle storie, di quelle versioni dialettali che molte volte coincidono con la tipologia di certe popolazioni, il carattere collettivo di certi clan, di certe genti, con quello che ereditiamo. Il lavoro di recupero di queste storie, di queste sfumature fiabesche, è appassionante.
Quando si fa un po’ di allenamento non solo si intravedono le corrispondenze con certi tipi di piante, ma anche con certe parti della stessa pianta, perché se di quella pianta esaminiamo le radici o la corteccia o il fusto o la foglia o il fiore, la pianta può esprimere caratteristiche e qualità differenti. Ecco perché nella teoria delle segnature non c’erano quasi mai le piante di tipo lunare o le piante di tipo mercuriale pure, ma erano dei misti. È attraverso questi grandi archetipi che impariamo che la luna è tutto ciò che è emozione, sogno, tutto quello che è acquoso, tutto quello che è sentimento, tutto quello che è trasporto emotivo. Allora ci sono certi tipi di piante che non hanno nulla a che fare con questa delicatezza, con questa dolcezza, con questa sensibilità… e altre invece tantissimo.
Allora se ad esempio il paziente – o tutto di lui – mi parla di una scarsa assertività (“Non riesco a farmi valere, non riesco mai a dire quello che penso, non riesco a esprimere la mia opinione, non riesco a chiedere un aumento, tutti vengono promossi e io no, non mi sento libero di fare quello che voglio”…), prima di tutto mi vengono in mente le scene dei film, che si imprimono forse con maggiore irruenza. In questo esempio la scena dell’Attimo fuggente in cui Neil tenta di confrontarsi con il padre: ecco che capiamo immediatamente tutti quanti, perché questo è il nostro substrato moderno delle narrazioni: chi non ha visto un film come questo, chi non ne ha ascoltato la profondità?
Una volta che abbiamo compreso il personaggio, che l’abbiamo intuito, che l’abbiamo afferrato con la coda dell’occhio, allora per analogia lo riconoscremo nelle fiabe o nelle storie. Lo riconosceremo magari in chi nelle fiabe si sente il grullo, quel terzo fratello che ogni volta che prova a dire qualcosa tutti lo prendono in giro, ridono di lui, che non ha nessun carisma e nessuna fiducia da parte di coloro che ha intorno. Allora già questo mi avvicina a quel paziente: mi sta raccontando la storia del grullo.
Quali sono le fiabe con il grullo come protagonista? Magari capiamo che la sua assertività mancata è in realtà il dispiacere di non aver fatto la scelta giusta in un bivio della sua vita, come nel film La vita è meravigliosa: volevo fare l’esploratore ma devo aiutare nell’azienda di famiglia e davanti a quel bivio ho rinunciato. È immediato per me pensare a una fiaba come Le tre piume, e una volta che ho la fiaba Le tre piume, dove qualcosa va verso l’alto – le piume – e qualcosa scende verso il basso – il grullo che si avventura sotto terra nel mondo delle rane -, con il paziente ci sarà da fare un lavoro di comunicazione della zona del pensiero con la zona più intima viscerale. E c’è soltanto una figura archetipica che può essere il governatore di questo viaggio supero e infero: sono tutte le divinità psicoponte ma più nel dettaglio la figura di Hermes, che mette in comunicazione. E guarda un po’, il problema della persona era proprio il comunicare.
Allora da questo sarà facile poi fare il passaggio successivo, che è intuire che probabilmente a quel paziente servirà una pianta più mercuriale, quando magari ad una prima analisi avremmo dato una pianta più marziale per la combattività, la violenza. Ma forse con la sua struttura non la reggerebbe, perché gli pare brutto, perché non è pronto, perché non si sente sicuro di se stesso, e così avanti. Trasformare tutto questo in un metodo accessibile, fruibile è un work in progress. Spero che potrò uscire a breve con un saggio manualistico proprio per dare delle linee guida in mezzo a tutta questa poesia, a tutta questa suggestione: un volume che appunto racchiuda le triple, trentupliche anime di questo percorso.
Ci hai parlato delle radici, della storia di Erboristeria Narrativa. Come immagini i suoi rami, il suo futuro? Che cosa c’è in arrivo per chi ti segue?
Adesso è soprattutto un lavoro di pubblicazione, di sensibilizzazione, di trasmissione orale di tutto quello di cui abbiamo parlato, oltre che uno strumento di cura quindi con le consulenze, con i pazienti. I prossimi progetti sono i viaggi, perché calarsi nel genius dei luoghi, stare a contatto con quel tipo di natura, con quel tipo di gente, col luogo topografico è un metodo che secondo me è più diretto, perché più immersivo e più stimolante ancora per la conoscenza e l’apprendimento di tutto questo. Ma anche per la parte esplorativa, emozionale e di condivisione, perché sono viaggi di gruppo.
C’è il progetto del libro, ma c’è anche un progetto che riguarda la collaborazione con più persone che diventano man mano appassionate di tutto questo, perché va da sé che questa materia è enorme, è quasi infinita e soprattutto è corale. E quindi il corso dell’Accademia di Erboristeria Narrativa è anche rivolto a future collaborazioni. Abbiamo bisogno di narratrici, abbiamo bisogno di erboattori, abbiamo bisogno di costruire dei parchi, abbiamo bisogno di parchi erbonarranti e abbiamo bisogno di illustratori, di traduttori, di interpreti, di chi conosce i dialetti, non solo le lingue; di chi ha voglia di copiare a mano la struttura di certe forme delle foglie e soprattutto tutto questo è rivolto proprio ad essere un’opera di ampliamento delle nostre conoscenze e capacità.
Grazie Roberta.
Mycelica®
Segui Roberta Schembri e la sua Erboristeria Narrativa sulla pagina FB e sul suo sito. Leggi alcune delle sue erbonarrazioni su Mycelica.
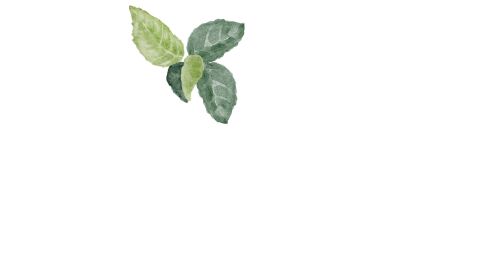



2 risposte
… Magia pura, ogni volta che Roberta racconta e leggo i suoi scritti, è pura magia…
È vero, abbiamo bisogno di fiabe, di miti, di infusi d’erbe e di stagioni per poterli gustare.
Grazie Roberta per portare tanto nutrimento ad ognuno dei nostri corpi con tanta passione, e grazie a Silvia per la ricchezza di domande.
Molto bello questo sito, lo leggo con curiosità ed entusiasmo 🌿
Grazie Francesca! Mentre la intervistavo sono caduta nella tana del Bianconiglio, Roberta fa sempre questo effetto!